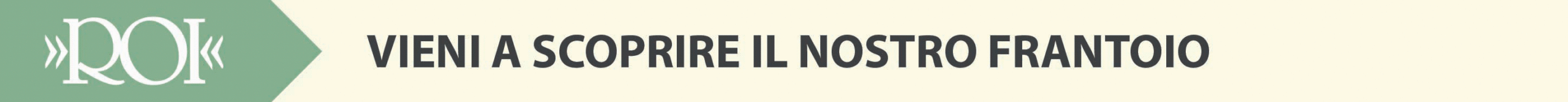Prosegue il ciclo di lezioni sul dialetto con Giannetto Novaro, figura unica che incarna lo spirito e le tradizioni della Liguria rurale. Uomo d’altri tempi e ‘castellotto doc’, Novaro conserva una memoria vivace e una conoscenza profonda delle radici culturali della sua terra, frutto di una vita trascorsa in armonia con i ritmi della natura e con i valori di una comunità che oggi rischia di scomparire.
La spiegazione di Giannetto Novaro ‘Chi u vö vé e uíve, u e vagghe a vé a’a stagiún de fighe‘
Ai nostri microfoni Novaro ha spiegato: ‘Chi u vö vé e uíve, u e vagghe a vé a ‘a stagiún de fighe‘- Chi vuol vedere se ci sarà abbondanza di olive, vada a controllare nella stagione dei fichi.
“Chi vuol valutare l’annata delle olive è meglio che lo faccia a settembre, alla stagione dei fichi”, ha spiegato Giannetto. “Il fiore dell’ulivo, i frutti in seguito, se abbondanti significavano un buon raccolto, significavano vendita di una parte dell’olio e spesso la sopravvivenza. L’ulivo non produceva abbondanti frutti tutti gli anni come certi alberi da frutto, produceva un anno sì e un anno no. L’ulivo è una pianta che fiorisce ad aprile e il racconto avviene da ottobre in seguito quindi i piccoli frutti restano appesi all’albero per almeno 6 mesi e in 6 mesi può succedere di tutto: siccità, grandine e poi c’era la famigerata mosca olearia. E ancora tanti imprevisti. Le olive si raccoglievano a mano e dopo la raccolta c’era anche la spesa del frantoio e una volta ottenuto l’olio bisognava venderlo e in quegli anni si pagava poco”.
“Quindi questo è un detto ottimista perché a settembre- dato che le olive si raccoglievano un tempo da metà ottobre in poi- c’era sempre un imprevisto, era sempre un’avventura”.
La spiegazione integrale di Giannetto Novaro nel video-servizio a inizio articolo.