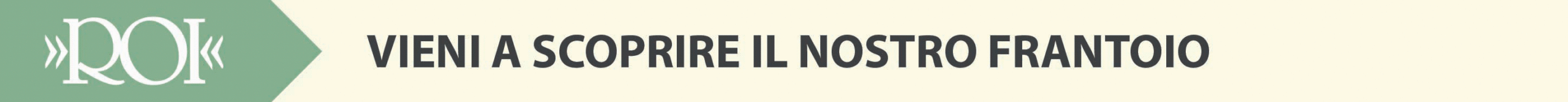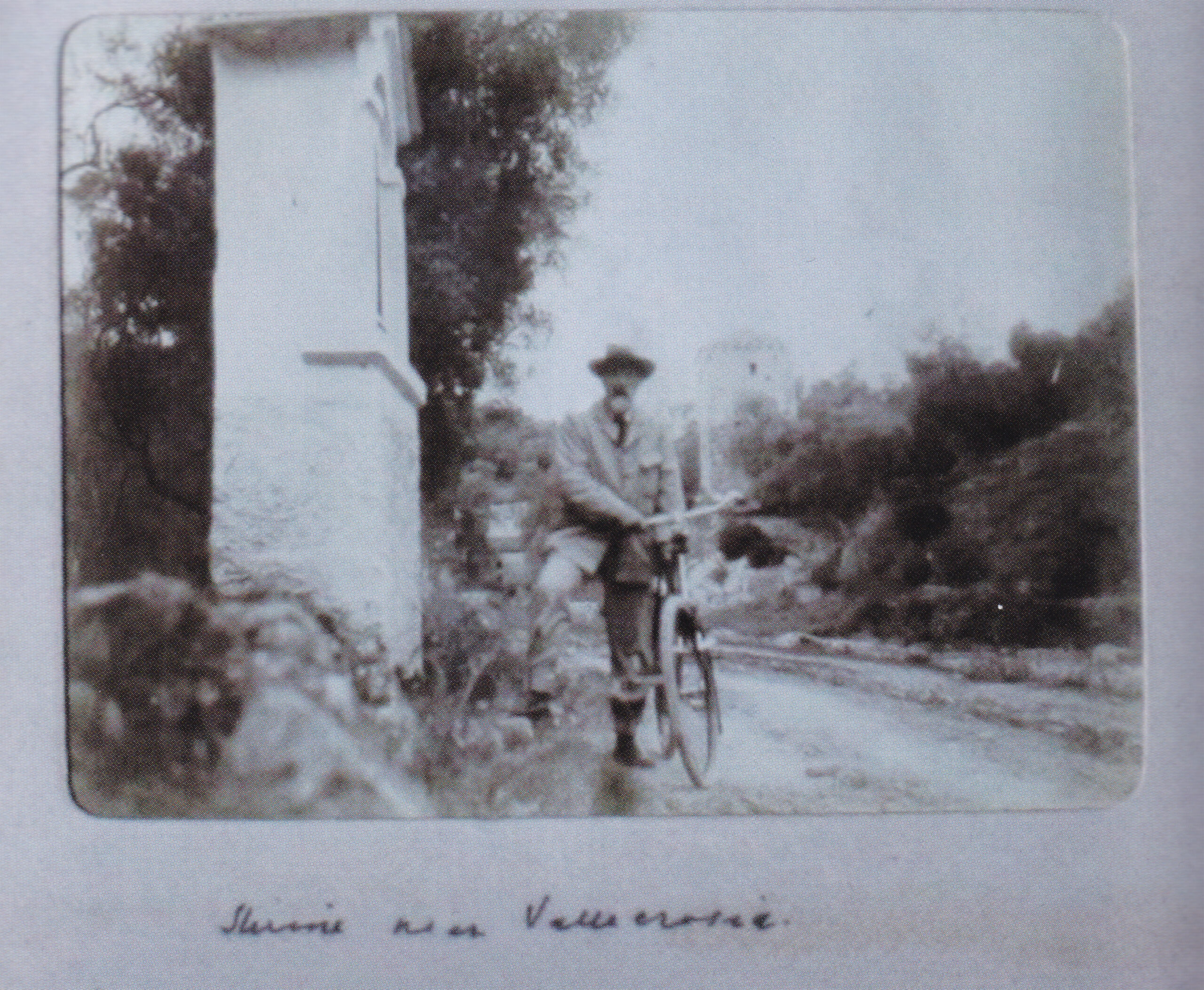Clarence Bicknell nacque il 27 ottobre 1842 a Hernhill, un sobborgo di Londra, da una famiglia agiata.
Il padre, Elkann Bicknell, commerciava olio di balena e aveva diverse conoscenze altolocate: il suo salotto era infatti frequentato da personalità di spicco, tra cui i pittori John Constable e Henry Ossawa Tanner, che influenzarono Clarence fin da bambino, trasmettendogli l’amore per l’arte. Con il tempo Bicknell si appassionò moltissimo alla tecnica dell’acquerello, dipingendo fiori e paesaggi, perché desiderava rilassarsi cogliendo la bellezza della natura.
La comunità inglese
Nel 1873 Clarence Bicknell si laureò in matematica all’Università di Cambridge e, cinque anni dopo, nel 1878, accettò l’invito di Rosa Walker Fanshawe a trasferirsi a Bordighera per assumere il ruolo di pastore presso la chiesa anglicana: la “All Saints Church“. Fu chiamato a diventare un punto di riferimento per la numerosa comunità inglese residente nella città, composta da benestanti attratti dal clima mite della città, resa celebre anche dal romanzo “Il dottor Antonio” di Giovanni Ruffini, scritto durante l’esilio dell’autore in Inghilterra.
Si formò così una vivace comunità britannica che trovava nella Riviera un clima ideale, dove prese piede anche l’elioterapia, pratica consigliata dai medici inglesi per i pazienti più fragili. Gli inglesi soggiornavano a Bordighera da novembre ad aprile, per poi rientrare in patria con l’arrivo delle temperature più calde.
All’epoca la città contava circa 3.000 inglesi a fronte di 2.000 residenti locali, trasformandosi in una località modellata sulle esigenze della comunità britannica: sorsero eleganti ville, raffinati alberghi e, naturalmente, il museo voluto da Clarence Bicknell.
Il Museo Bicknell: “Un luogo di raccoglimento e di pace”
Nel 1886 Clarence Bicknell avviò la costruzione del suo museo, un progetto ambizioso che durò due anni e si concluse nel 1888. Con la sua apertura, il Museo Bicknell divenne il primo museo privato in Liguria accessibile al pubblico.
Fu costruito per offrire alla comunità inglese un luogo di raccoglimento e di pace, “un posto dove riunirsi”, come lo definì lo stesso Bicknell. Il museo divenne presto un vivace centro culturale, dove si tenevano concerti e spettacoli teatrali. I paraventi in tela di iuta, visibili ancora oggi, furono realizzati dagli amici pittori Giuseppe Piana e Friederich von Kleudgen e utilizzati come scenografie per le rappresentazioni. In particolare, il paravento di Piana raffigura quattro delle cinque arti; nella parte superiore compaiono gli stessi artisti – Piana, Pompeo Mariani, von Kleudgen e Kurt Nessel – autoritratti con un’aureola, in un gesto ironico di autocelebrazione della loro arte.
L’amore per la natura
Bicknell rimase profondamente affascinato dalla ricchezza della flora della Riviera di Ponente, in particolare delle zone di Bordighera e Sanremo. Le sue ricerche e osservazioni confluirono nel volume “Flora di Bordighera e di Sanremo“, frutto di anni di studio.
Il museo conserva ancora oggi le preziose collezioni di Clarence Bicknell, testimonianza dei suoi vasti interessi: dall’erbario alle raccolte naturalistiche e artistiche, fino a quella che divenne la sua più grande passione negli ultimi vent’anni di vita – le incisioni rupestri del Monte Bego, della Valle delle Meraviglie e delle valli circostanti. Bicknell le documentò con la tecnica del frottage, che consisteva nel poggiare un foglio di carta sulla roccia e ricalcarne i segni con estrema precisione, un lavoro paziente svolto insieme al suo fedele assistente Luigi Pollini.
Tra le prime collezioni, e forse la più significativa all’epoca, vi è l’erbario: una raccolta di piante essiccate provenienti da tutta la provincia, dal mare fino ai monti Toraggio e Pietravecchia. Si tratta di un lavoro rigoroso e scientifico di raccolta, essiccazione, catalogazione e esposizione dei campioni, che ancora oggi rappresenta uno dei tesori più preziosi del luogo.
Il museo era anche un vero e proprio centro di ricerca. Botanici provenienti da tutta Europa vi si recavano per studiare l’erbario, mentre chi non poteva raggiungerlo riceveva i campioni per corrispondenza. Ancora oggi, numerosi esemplari raccolti da Clarence Bicknell sono conservati in prestigiosi giardini botanici e istituti scientifici europei.
La bicicletta
Tra le passioni più grandi di Bicknell vi fu la bicicletta, che amava utilizzare per le sue escursioni tra la costa e l’entroterra. Durante le sue escursioni all’aria aperta, il matematico non si limitava a camminare: già nel 1891 la bicicletta lo accompagnava nelle sue ricerche. In una sua lettera scherzava sul timore di non riuscire a pedalare, visto il suo peso di 92 chili.
Oggi, la ciclovia intitolata a Clarence Bicknell ripercorre le sue tappe alla ricerca dei campioni per l’erbario, fino ad arrivare a Tenda, punto di partenza delle sue campagne archeologiche per lo studio delle incisioni rupestri.
La sua eredità
Il suo amore per la natura e per la ricerca non si fermò mai: Clarence Bicknell morì nel 1918 a Casterino, nella sua casa di montagna, vicino alle sue amate Alpi, alla flora e alle incisioni che aveva tanto studiato.
Dopo la sua morte, l’eredità del museo e della sua straordinaria impresa culturale fu raccolta dai nipoti Edward e Margaret Berry.
Sarà proprio sua nipote Margaret a incontrare un giovanissimo Nino Lamboglia, che fonderà qui l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, proseguendo idealmente l’opera di Clarence Bicknell.
Nel video servizio a inizio articolo, i bibliotecari Elena Riscosso e Giovanni Russo ci portano alla scoperta della figura di Bicknell. Le immagini storiche sono state realizzate con l’IA.