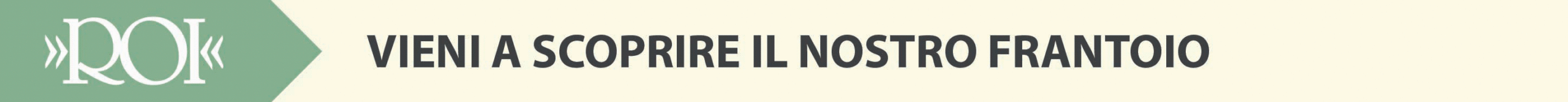Il 4 novembre 2025 ricorrono i 30 anni dalla morte di Amilcare Rambaldi.
Una figura che ai posteri può definirsi decisiva per la storia culturale di Sanremo del dopoguerra, associato in particolare alle manifestazioni musicali della città.
Nato il 5 aprile 1911, Rambaldi non era però un uomo di spettacolo, né un un artista professionista. Di base tutt’altro.
Diplomato in ragioneria, lavorò per gran parte della sua vita tra i fiori, settore che rappresentava l’economia principale del territorio. Ma fin da giovane mise in mostra un forte senso civico e una vocazione naturale per la cultura, recitando a teatro, coltivando interessi artistici e impegnandosi in maniera sempre più determinata nella vita sociale cittadina.
Il suo percorso di vita include anche l’esperienza su campo di battaglia.
Dapprima, tra il 1935 e il 1937 partecipò alla campagna d’Etiopia, poi successivamente fu richiamato alle armi nella Seconda Guerra Mondiale fino al 1943.
Entrò nelle formazioni partigiane dell’Alta Valle Argentina durante la Resistenza. Terminato il secondo conflitto mondiale tornò a Sanremo.
Nel 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale lo nominò presidente della sottocommissione artistica incaricata di proporre idee per rilanciare il Casinò Municipale e l’economia cittadina attraverso una serie di eventi e spettacoli. Nel novembre di quell’anno Rambaldi presentò quindi una relazione ricca di proposte.
Fra queste già allora compariva l’idea primordiale di un festival musicale che potesse avere un respiro nazionale.
Quella relazione non venne però accolta, ma quel documento ancora oggi può essere considerato come l’atto di concepimento del futuro Festival di Sanremo.
Nel 1947 arriva l’incontro con Angelo Nizza, un autore radiofonico all’epoca di successo, con cui nacque un sodalizio che risulterà decisivo.
Fu con lui infatti che Rambaldi insistette perché sostenesse l’idea di un festival canoro presso la direzione del Casinò.
Dopo 4 anni di insistenze, tentativi e pianificazioni sempre più concrete, il 29 gennaio 1951 andò quindi in onda la prima edizione del Festival della Canzone Italiana, trasmessa in diretta radiofonica dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e condotta da Nunzio Filogamo.
Dobbiamo immaginarci i primissimi Festival di Sanremo come un qualcosa di molto diverso da oggi.
Quando pensiamo a Sanremo nell’immaginario collettivo odierno pensiamo, al di la dell’Ariston, alla sfilata dei grandi cantanti, spesso di grande fama che si avvicendano sul palco concorrendo al titolo di vincitore. Un immaginario oggi ben visibile fra i ciotoli di Via Matteotti(c’era anche quella fra le idee di Rambaldi, ma ci torniamo dopo).
Ma il nome completo della kermesse sanremese è “Festival della Canzone Italiana”.
E di fatti, sul palco del Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, le canzoni in gara per quella prima edizione furono 20, ma i cantanti furono 3: Achille Togliani, il Duo Fasano e Nilla Pizzi, che poi farà vincere “Grazie dei Fiori”, scritta da Giancarlo Testoni e Mario Panzeri e musicata da Saverio Seracini.
Solo in seguito, il festival assumerà progressivamente la sua forma attuale.
Il successivo bivio per la sua storia(e quella della città e della musica italiana) arrivò poi nel 1967.
Profondamente colpito dalla morte di Luigi Tenco, decise di dare un nuovo senso al rapporto tra musica e cultura.
Fu quindi, in ironicamente, in quasi reazione rispetto alla creatura che aveva contribuito a fondare, che nacque il Club Tenco, con l’obiettivo di promuovere una canzone “di maggior impegno poetico, culturale e sociale”.
La morte del cantautore, in maniera simile a come pochissimi anni più tardi sarebbe successo per Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, colpì profondamente l’opinione pubblica. Le dinamiche della tragedia, che diederò alla faccenda connotati “politici”, contribuirono a creare un sentimento di rivalsa nei confronti di un certo modo di intendere la musica italiana.
Nel 1974 nacque così la Rassegna della Canzone d’Autore – Premio Tenco, che Rambaldi descrisse nel diario del primo giorno come “una gestazione travagliata” ma nata “nello spirito di amicizia” e “lontana da ogni forma di ufficialità”.
Nel 1978 viene riconosciuto dal Comune di Sanremo come “cittadino benemerito”, in un periodo, quello finale della sua vita, dove riceverà numerosi riconoscimenti per il contributo svolto tanto per la città, quanto per la musica.
Si spegne il 4 novembre 1995, all’età di 84 anni, nel sonno, dopo aver inciso, forse più di chiunque altro, a plasmare l’immaginario che oggi caratterizza buona parte della sua città.
Uno dei più riusciti tributi a lui dedicato è la raccolta di brani pubblicata nel 1999 dal titolo “Roba di Amilcare”, compilation di registrazioni inedite eseguite quasi tutte durante le serate del Premio Tenco al Teatro Ariston e che vede, la partecipazione di un gran numero di grandi autori italiani, da Ligabue a Gino Paoli, Vinicio Capossela, Jovanotti, Francesco Guccini e Fabrizio(e Cristiano) De Andrè.
Fra brani inediti e grandi classici del cantautorato italiano, risaltano due brani dedicati proprio alla figura di Rambaldi, l’elegante “Roba di Amilcare” di Paolo Conte, che da il titolo alla raccolta e lo scanzonata dedica di Roberto Benigni.
“Rambaldi, che fa un po di confusione fra il Club Tenco e i Fiori ieri in Belgio gli hanno chiesto le gardenie e ci ha spedito De Gregori. Rambaldi, che i più grandi musicisti in questo palco ha messo in fila. Rambaldi, che è capace il prossimo anno a far cantare qui Wojtyla.” (Roberto Benigni – “Amilcare Rambaldi”)