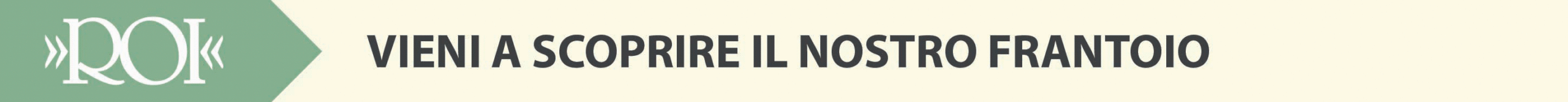Tra il 19 e il 26 aprile 1920, Sanremo divenne per una settimana il centro del mondo.
Nel Castello Devachan, villa liberty affacciata sulla collina del Berigo, si riunirono le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale per discutere la spartizione dei territori dell’ex Impero ottomano. Fu un vertice i cui effetti a lungo termine ebbero proporzioni storiche.
In quella villa di villeggiatura, tra carte e sigari, nacquero le basi del moderno Medio Oriente, ma non solo.
Gli antefatti
La Grande Guerra aveva lasciato dietro di sé imperi crollati e confini da ridisegnare. Il secondo Reich, l’Austria-Ungheria e Impero Ottomano non esistevano più.
Già durante il conflitto, Francia e Gran Bretagna avevano stretto accordi segreti per spartirsi l’area del Vicino Oriente.
Il più noto fu l’accordo Sykes–Picot del 1916, che tracciava linee sulla mappa tra Siria, Iraq e Palestina ancor prima della vittoria.
Pochi mesi dopo arrivò la Dichiarazione Balfour (1917), con cui Londra appoggiava l’idea di una “casa nazionale per il popolo ebraico” in Palestina, senza intaccare i diritti delle comunità già presenti.
Nel frattempo, nel mondo arabo cresceva il sogno di indipendenza: le rivolte anti-ottomane, sostenute dagli Alleati e guidate dallo sharif della Mecca Ḥusayn e dai suoi figli, avevano alimentato l’idea di un grande regno arabo. Ma, alla fine del conflitto, le potenze europee mostrarono di avere altri piani.
La conferenza di Sanremo
Sanremo, città elegante e cosmopolita, fu scelta per ospitare il Consiglio supremo alleato, con i rappresentanti di Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone: arrivarono il primo ministro britannico David Lloyd George, quello francese Alexandre Millerand(che di lì a poco sarebbe divenuto presidente), il presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti e l’ambasciatore Keishirō Matsui.
Erano presenti anche Grecia e Belgio, mentre gli Stati Uniti inviarono osservatori senza diritto di voto.
Il Castello Devachan, allora una delle dimore più prestigiose della città, venne trasformato in quartier generale della diplomazia.
Lì, tra il 19 e il 26 aprile, si discusse il destino di milioni di persone: alla Gran Bretagna furono affidati i mandati sulla Palestina e sulla Mesopotamia (oggi Iraq), alla Francia quelli sulla Siria e sul Libano.
Si decise inoltre di internazionalizzare gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, garantendo il libero passaggio tra Mediterraneo e Mar Nero.
Non tutto fu risolto. Nel corso delle trattative ci si aspettava che vi fosse uno spazio per la Questione adriatica, cruciale per l’Italia, che però venne rimandata a ulteriori trattative, che si sarebbero concluse solo a novembre con il Trattato di Rapallo.
Per Roma, che ebbe quindi scarso ritorno politico rispetto alle aspettative maturate prima e dopo la guerra, fu l’origine del mito della “Vittoria mutilata”.
Le conseguenze
Le decisioni di Sanremo furono poi ratificate dal Trattato di Sèvres (agosto 1920) e formalizzate dal Consiglio della Società delle Nazioni nel luglio 1922.
La Turchia, dopo molta reticenza, accettò solo dopo la firma del Trattato di Losanna del 1923, che ne definì i confini moderni.
Da Sanremo uscì un nuovo equilibrio mondiale: il mandato britannico in Palestina avrebbe condotto, trent’anni più tardi, alla nascita dello Stato di Israele; quello francese in Siria e Libano avrebbe lasciato un’impronta duratura sulla politica del Levante.
Per l’Italia, rimase l’amarezza di aver ospitato un tavolo da cui le decisioni più pesanti erano già state prese altrove.
Oggi, a più di un secolo di distanza, la conferenza di Sanremo resta uno dei capitoli meno conosciuti ma più influenti della storia del Novecento.
Una settimana di primavera, in una città di mare, in cui si decise il destino di interi popoli.