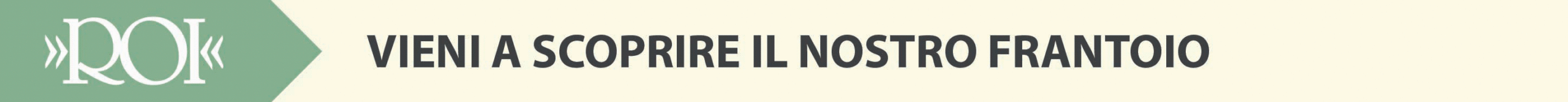Quando si parla di conflitti navali, blocchi, abbordaggi e navi umanitarie fermate in alto mare, la domanda che anima maggiormente i dibattiti che ne seguono nell’opinione pubblica è tendenzialmente su cosa sia legale e cosa no.
In assenza di un trattato moderno che disciplini la guerra sul mare, il riferimento più solido resta un documento che fu redatto nella nella “Città dei Fiori” e, dopo una lunga serie di riunioni in giro per il mondo, completato a Livorno il 12 giugno del 1994.
Composto da 21 pagine e 183 paragrafi, il Manuale di San Remo sul diritto applicabile ai conflitti armati in mare non è un trattato firmato da Stati, ma una codificazione di regole e principi che nel tempo è diventata de facto uno standard a livello globale.
Pur se non vincolante, è citato da governi e marine militari nelle dottrine operative, viene utilizzato da tribunali e commissioni internazionali per valutare la legalità di blocchi o abbordaggi, ed è adottato da ONG e organizzazioni umanitarie come riferimento per monitorare il rispetto del diritto in mare.
Come funziona e perché è importante
Il Manuale non inventa nuove leggi, ma raccoglie e ordina quelle già esistenti, traducendole in regole pratiche. Si rifà in particolare alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai Protocolli aggiuntivi del 1977, alla Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) e ad altre norme consolidate del diritto internazionale.
Stabilisce quando un blocco navale è legittimo, come devono comportarsi le navi militari con quelle neutrali e quali limiti porre all’uso della forza.
Fra le regole principali: un blocco navale deve essere dichiarato e notificato e non può avere come obiettivo l’affamare la popolazione civile, le navi neutrali possono essere fermate o ispezionate solo con motivi fondati e seguendo procedure precise, l’uso della forza deve rispettare i principi di proporzionalità, distinzione e precauzione, gli aiuti umanitari non devono essere arbitrariamente impediti.
Per questa chiarezza, il Manuale resta probabilmente il testo di riferimento più completo ad ora mai prodotto.
Storia e radici
Prima del 1994, il diritto marittimo di guerra era disciplinato da testi ormai datati, come le Convenzioni dell’Aia del 1907 e l’Oxford Manual del 1913. Erano regole pensate per un mondo di flotte regolari e guerre tra Stati, lontano dalle guerre asimmetriche e dal coinvolgimento crescente dei civili, che divenne manifesto con la Seconda Guerra Mondiale.
Emerse quindi l’urgenza di aggiornare queste norme. Fu l’International Institute of Humanitarian Law, che dal 1970 ha sede a Sanremo, a farsi promotore di una serie di incontri internazionali che riunirono giuristi, diplomatici e ufficiali navali da tutto il mondo. Tra il 1988 e il 1994, proprio nelle sale di Villa Ormond(ancora oggi sede dell’IIHL) e nel corso di altre riunioni in altre città del mondo come Madrid, Bochum, Tolone e Ottawa, prese forma il Manuale: un testo che traduceva i principi generali del diritto umanitario in regole operative per il mare. Da allora porta il nome della città che lo ha visto nascere.
Dalla Commissione Palmer alla Global Sumud Flotilla
Il Manuale di San Remo è stato più volte richiamato nella prassi internazionale. Un caso noto è quello della Freedom Flottiglia per Gaza del 2010, quando le forze israeliane abbordarono una delle imbarcazioni, la nave turca Mavi Marmara in acque internazionali. Una commissione d’inchiesta dell’ONU, la Commissione Palmer, utilizzò proprio il Manuale per valutare la legalità dell’operazione ,stabilendo che, in astratto, il blocco navale israeliano poteva considerarsi conforme al diritto internazionale, ma giudicando le modalità dell’abbordaggio, che causarono 10 morti e innumerevoli feriti sproporzionate e contrarie ai principi fissati dal Manuale. Il rapporto Palmer fu sin da subito molto criticato, e un successivo rapporto della Commissione d’inchiesta del Consiglio diritti umani dell’Onu, nello stesso anno stabilì l’illiceità del blocco navale, in base all’art. 33 della IV Convezione di Ginevra.
Oggi, con la Global Sumud Flotilla, le stesse questioni riemergono. Israele rivendica il blocco come misura di sicurezza(rifacendosi anche al manuale), ma le operazioni di abbordaggio in acque internazionali, l’uso della forza e l’ostacolo agli aiuti umanitari vengono considerati da moltissimi osservatori non conformi né al diritto internazionale né allo stesso Manuale di San Remo. Quest’ultimo, infatti, vieta che un blocco abbia come effetto l’affamare la popolazione civile o impedire arbitrariamente i soccorsi.
Un Manuale da aggiornare
A trent’anni dalla sua pubblicazione, il Manuale resta fondamentale ma non sufficiente. Le nuove tecnologie come droni navali, sistemi d’arma autonomi, guerra cibernetica, pongono sfide che il testo del 1994 non poteva prevedere.
Per questo, dal 2019 è in corso un processo di revisione coordinato dallo stesso Istituto di Sanremo. L’obiettivo è aggiornare il documento senza tradirne i principi, confermando il suo ruolo di standard internazionale per la guerra in mare.
Testo che è possibile consultare integralmente, in lingua inglese dal sito dell’ IIHL, ma anche tradotto in lingua italiana a cura della Croce Rossa, nel 1997.